La gioia di uccidere, di Harry MacLean
Risuona, nel buio di una notte invernale, il ritmo dei tasti di una vecchia Underwood. Tocchi leggeri evocano e decidono colore e intensità: nero profondissimo, rosso vermiglio di un sangue nel quale specchiare i ricordi, i pensieri. Le giustificazioni.
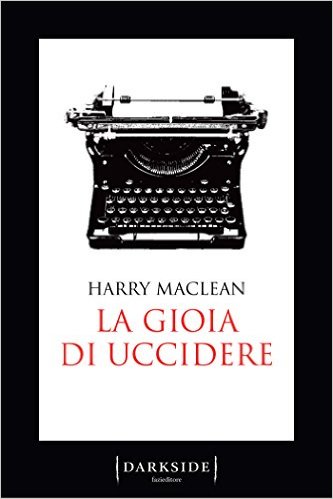
“La gioia di uccidere! La gioia di vedere l’omicidio compiuto – questi sono tratti distintivi della natura umana in generale”. Parole di Mark Twain che Harry MacLean riporta nel suo La Gioia di Uccidere, un racconto sospeso tra presente e passato e intriso di umori, ricordi; un crescendo di umano dolore, una ferita che si slabbra a poco a poco.
Sono passati 40 anni da quando il giovane ha smesso di essere adolescente. Ha risposto a un bisogno lontano nel tempo, al bisogno di tornare nella casa delle estati della sua infanzia – il lago davanti, i ricordi alle spalle. Sono luoghi che stridono, che si gonfiano di energia vitale, come succede con ciò che ci appartiene e che ci circonda: si riempie, a poco a poco, della forza del dolore. Tornare, attraversare quelle mura, significa misurarsi con la necessità di riportare a galla ogni pezzo che compone la propria identità, la propria storia, mettere insieme i tasselli confusi dalla nebbia del tempo per poterne scrivere.
L’adolescente che è stato prima professore, e poi scrittore, ha bisogno di deporre le armi e tramutare le ferite in parola, per non sentire tutto quel dolore, o forse per sentirlo più forte.
C’è David, amico di sempre, che si scopa tua moglie, e ti chiedi quanto e se veramente ti importa. C’è Joseph, che allunga la mano per afferrare la tua spalla prima di infilarsi nel gorgo d’acqua che lascia la vita a te rubandola a lui e un po’ a coloro che restano, che da quel giorno smettono ugualmente di vivere e tornano ad affiorare, fantasmi del passato, per ricordarti la colpa. C’è la traccia di sangue che da parte a parte del bellissimo collo di Shelley si apriva all’infima morte.
I fantasmi ritornano e per liberarsene bisogna imprigionarli su fogli di carta. Imprigionare il lercio, il tanfo del pedofilo Willie, la sua gamba sbilenca, la sua morte in un vicolo schifoso, lui che aveva promesso ai due amici adolescenti un incontro con una deliziosa ragazza che poteva regalare a due ingenui ragazzini la prima esperienza e che poi, come una brutta fotografia, è apparsa sopra di loro con la sua orrida sporcizia morale. Giustificarlo? Come giustificare la natura umana che compie e chiede, o non chiede perdono, ma segue la corrente del suo istinto primordiale?
C’è un continuo tam tam di immagini in queste pagine e una componente fortissima di filosofia, presente nel libro del Professore, in cui l’Io narrante si dibatte tra la propria identificazione e quella da parte degli altri, quegli altri che gli hanno aperto la porta dell’Università per farlo andare via quando sembrava troppo difficile riconoscere in quell’uomo colui che aveva squarciato la vita della moglie. Giustificabile anche lui?
A volte mi pare che per tutta la vita io mi sia trascinato dietro la mia storia come un pesante macigno che non sono mai riuscito a vedere. Ma stanotte sono assolutamente sveglio, e sto iniziando a preoccuparmi di questa oscurità così effimera. Tutto mi si rimescola nella mente.
Un vortice di violenza, erotismo, innocenza. Il libro del Professore è in parte chiave. Serve ad aprirsi con forza alla lama della verità. Una scrittura sfacciatamente vera, cruda e crudele, e un lungo sottile filo che unisce il ricordo alla lama che taglia il passato e il presente. Il castello di evocazioni di MacLean si forma e si disfa sotto i nostri occhi continuamente, pagina dopo pagina, in un noir intriso di dolore fisico e verità inaccettabili. Lo leggerete d’un fiato, e il fiato vi mancherà fino alla fine, senza congetture, squarciando convinzioni, sconvolgendovi nella brutalità di una inaspettata verità. Fine dell’innocenza.
