La sublime arte, di Alexandra David-Néel
L’arte ha un povero Dio, recitava un verso di una canzone dei Timoria, un bel po’ di anni fa. L’arte pura è quella cui tende chi ambisce al sublime, alla gioia, al pieno godimento di essere venerato/a per il semplice fatto di esistere, di possedere quel talento non comune che rende immortali.
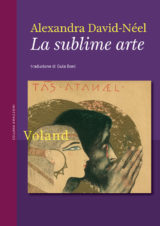
Ma c’è anche la realtà, con cui tutti dobbiamo fare i conti. La realtà delle alterne fortune, dei disastri, dei dissapori, degli inganni e delle occasioni perdute. La realtà del denaro che manca, della futilità e allo stesso tempo della inoppugnabile importanza del mangiare, del vestire, del vivere lontani dai disagi.
Quante storie di artisti ho e abbiamo letto e ascoltato nel tempo e, gira e rigira, si somigliano tutte? Quanti personaggi diventati famosi sono stati, agli inizi, sull’orlo del baratro?
La sublime arte (Voland, trad. di Guia Boni) è un libro intenso, scritto in maniera impeccabile da Alexandra David-Néel, una esploratrice e scrittrice di talento della quale avevo già avuto piacere di leggere, in passato, un libro dal titolo veramente curioso: Nel paese dei briganti gentiluomini (edito in Italia sempre da Voland).
A dire il vero, questo romanzo è precedente, ed è stato pubblicato solo nel 2018, in Francia, e in seguito nel nostro Paese.
Cécile Raynaud, ambiziosa cantante di teatro, inizia a scrivere un diario in cui decide di svelare sé stessa, i pensieri più reconditi e le angosce e le paure più pesanti. Le pagine del diario, così, ci raccontano prima i ricordi di un passato avventuroso, alla ricerca del successo e della gioia dell’affermazione, vissuto tra mille viaggi, incertezze e situazioni di alterna fortuna. Ma non sarebbe un vero diario se le pagine non riprendessero la realtà, la vita di tutti i giorni. Giorni fatti di speranze, spesso vane, di un rincorrere soggetti che promettono ma mai mantengono, riscuotendo o pretendendo di riscuotere il pegno d’amore, la totale dissolutezza della donna che cede a causa di una situazione al limite dell’indigenza. Cécile sperimenta, perciò, l’inganno sotto varia forma, lo subisce così come comprende che innamorarsi potrà portarle solo dolore, sfinimento, irragionevoli tremori.
Ma tutto passa, in nome dell’arte:
“…l’incantesimo, l’illusione che mi ha fatto approdare al teatro come in un tempio sacro, rivivono e mi possiedono… Dimentico le esperienze vissute, i ridicoli palcoscenici e la mia vita miserabile… Dimentico chi sono, cosa sono… l’irreale mi trascina: l’arte, creatrice di chimere, dispensatrice di sogni, l’arte sublime, che gli uomini mediocri sviliscono…”
E così, quando le si presenta l’occasione da sfruttare, con coraggio e trattenendo il respiro, decide di tentare l’ultima carta, quella che potrebbe portarla al successo.
Ed è proprio quando ciò accade, quando la fama le fa apparire diverso il mondo che la fame — perdonate il gioco di parole — prima le aveva presentato in modo crudele, Cécile apprende che il cinismo che tanto aveva vituperato può essere non soltanto subìto, ma anche praticato al cambiare del contesto.
Il cinismo, quindi, come cura, come soluzione per non incappare nelle sofferenze patite negli anni prima:
“…Così, come avevo guardato Georges, guardai anche lui, algida e dura, ma non trovai i suoi occhi; il viso glabro e pallido, impassibile, come una statua di cera, era chino sull’indumento steso sulle braccia…”
Un testo vibrante, un appassionato e appassionante ritratto di un’epoca decadente, ben preciso nel raccontare i vizi (tanti) e le virtù (poche) di gente che navigava nell’ipocrisia, fingendo valori instabili, incerte certezze.
